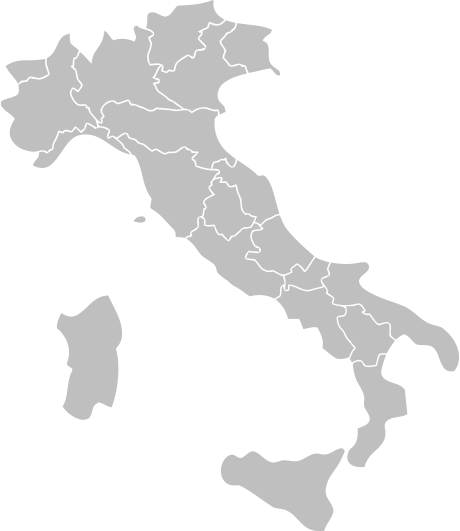A cura della tirocinante Indre Bieliunaite
“La vita di Adele” è un film del 2013 diretto da Abdellatif Kechiche, che racconta una complessa storia d’amore tra due giovani donne Adele ed Emma. Adele è una giovane donna che cerca di trovare il suo vero io e il suo posto nel mondo. La sua vita cambia quando incontra Emma, che le porta una nuova luce nella sua vita, forti sentimenti e un nuovo mondo da esplorare. Il film esplora la natura sfaccettata dell’orientamento sessuale, le pressioni sociali e le relazioni interpersonali.
Chi meglio di Sigmund Freud può esplorare la complessità dell’omosessualità? Questo articolo esplorerà le teorie di Freud e le sue intuizioni sulla sessualità, che sono state molto influenti nel XX secolo, ma che hanno un valore di conoscenza da offrire anche oggi.
Il fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud, ha esplorato ampiamente l’omosessualità nelle sue opere. Egli trasse diverse osservazioni e fece luce da vari punti di vista: dall’influente lavoro sulla natura dello sviluppo sessuale, cioè il ruolo della sessualità infantile nella vita del bambino, al ruolo della sessualità infantile nella costruzione della sessualità adulta (1905), al ruolo del narcisismo nella direzione della scelta dell’oggetto (1910), alle identificazioni edipiche nell’organizzazione della psiche – il tema dell’Io e dell’Es (1923), alla natura della sessualità femminile (1931), al ruolo dell’aggressività nel conflitto tra l’inclinazione bisessuale all’interno della personalità (1937). In generale, assunse una posizione distante e non giudicante, consapevole dell’impatto degli atteggiamenti sociali e dell’influenza culturale e fu uno psicoanalista influente nel riconoscere l’omosessualità in una posizione non patologica. In una lettera alla madre del 1935 scrisse che l’omosessualità non è “nulla di cui vergognarsi, nessun vizio, nessuna degradazione, non può essere classificata come una malattia”.
Nella sua opera “Tre saggi” (1905) Freud sostiene con forza che ogni forma ed espressione della sessualità umana è il risultato di un’evoluzione complessa, che si sviluppa nel tempo, a partire dalla prima infanzia e dal primo rapporto con la madre (cioè la prima seduttrice) e passa attraverso fasi di differenziazione e sviluppo. Un attaccamento troppo intenso e schiacciante viene mantenuto e tuttavia ristrutturato prendendo come oggetto un amante basato sul sé, mentre il soggetto si identifica con la madre premurosa ma schiacciante e potente.
Inoltre, l’assunto più significativo di Freud (1905) in relazione all’omosessualità è che ogni individuo è dotato di una bisessualità innata (che ha basi sia biologiche che psicologiche).
Nella sua opera successiva “Analisi terminabile e interminabile” (1937) la bisessualità è considerata correlata all’omosessualità, nel senso che l’omosessualità si sviluppa, ma la bisessualità è il fondamento, con un’enfasi sulle manifestazioni psicologiche o fisiche, di solito entrambe. Pertanto, la bisessualità è l’inizio di tutte le sessualità, compresa l’omosessualità. Nella stessa opera (1937) Freud spiega che il conflitto interno spesso si sposta tra aspetti eterosessuali e omosessuali all’interno dello stesso individuo, attraverso il ruolo della ”libera aggressività”, la distruttività (identificata con l’istinto di morte) che fa luce sul conflitto interno.
L’esplorazione iniziata con il suo lavoro nel 1905 era un modo per decostruire i comuni assunti sulla normalità, minando ogni semplice nozione di normalità e patologia, mascolinità e femminilità. L’omosessualità è stata un aiuto alla sua concettualizzazione dell’istinto (costellazioni psichiche), o delle pulsioni (pulsioni di vita o di morte), allentando il presupposto convenzionale dell’epoca dell’inseparabilità tra istinto e oggetto. Concentrandosi sull’omosessualità come legata alla scelta dell’oggetto piuttosto che all’istinto, Freud sosteneva che l’istinto o le pulsioni sono aspetti della normalità. Descrive la pedofilia, la necrofilia, il sadomasochismo, nessuno dei quali è specificamente implicato nelle inversioni (sceglie la parola inversione come termine meno patologico per l’omosessualità).
L’omosessualità non è considerata in questa luce come patologica, sebbene sia collegata nei Tre saggi (1905) a un fallimento dello sviluppo, uno dei tanti arresti e inibizioni che complicano l’evoluzione verso l’eterosessualità adulta. Inoltre, Freud insisteva continuamente sul fatto che la scelta oggettuale omosessuale è normale in origine e che (la scelta oggettuale omosessuale) è un fatto di ogni esperienza infantile. Infatti, spiegava che tutti gli esseri umani hanno fatto questa scelta oggettuale nel loro inconscio.
Nella sua opera successiva “La psicogenesi di un caso di omosessualità in una donna” (1920) considerava l’omosessualità come una varietà di funzione sessuale, risultante da un certo arresto dello sviluppo sessuale (come detto prima), il che significa che l’omosessualità potrebbe essere dovuta a un arresto libidico (nello stadio fallico) dello sviluppo psicosessuale o al mancato raggiungimento dello stadio psicosessuale finale della genitalità a causa di un blocco della forza energetica (Kernberg, 2002).
Freud sosteneva che un elemento omosessuale è presente in tutti, per tutta la vita, dove la libido oscilla tra oggetti maschili e femminili. Pur affermando un arresto dello sviluppo, sosteneva che molte persone avrebbero adottato l’omosessualità senza le pressioni sociali esistenti e che il percorso verso la sessualità adulta non è semplice. Freud considerava l’omosessualità come un fenomeno, al pari di qualsiasi altro, da esplorare e illuminare attraverso la psicoanalisi, i meccanismi che portavano alla determinazione della scelta dell’oggetto, riconducendoli alle disposizioni istintuali.
Nel suo L’Io e l’Es (1923), affronta il complesso di Edipo nella sua forma completa (relazione d’amore con il genitore dello stesso sesso – Edipo negativo – e amore per il genitore di sesso opposto – Edipo positivo) e nelle sue forme parziali, mettendo il bambino in relazione con tre poli. Il lato negativo è considerato la rivalità. L’identificazione con il padre (nel caso di un figlio maschio) pone un problema perché diventa un’identificazione non con un oggetto d’amore ma con un rivale, qui la relazione con lo stesso sesso diventa una relazione omosessuale. In questo caso di complesso di Edipo negativo (o invertito), un ragazzo cerca l’amore del padre e l’identificazione maschile assumendo un’identificazione femminile che ritorna all’erotismo anale (come esplorato nelle opere di Freud 1920, 1922).
Per quanto riguarda l’omosessualità femminile, Poluda (2020) ha sottolineato che l’atteggiamento omofobico primario, inconscio, della madre è il fattore determinante dello snodo cruciale della bambina dalla madre al padre. Un complesso di Edipo primario negativo è una disposizione universale nelle donne, inibita dalla difesa omofobica inconscia della madre. Freud (1920) descrive un caso di omosessualità femminile come una predominanza del complesso edipico negativo come difesa contro quello positivo represso. Inoltre, secondo Melanie Klein, i conflitti preedipici primari della bambina con la madre possono determinare il trasferimento di tali conflitti (in particolare l’aggressività) sulla relazione con il padre, facendo emergere l’invidia del pene e il rifiuto della posizione femminile. Seguono, perciò, la scissione difensiva dell’immagine materna in una persecutoria ed idealizzata ed anche l’orientamento sessuale che si spinge verso tale immagine materna idealizzata.
Tenendo conto di tutto ciò, Freud ha sfidato la comprensione della sessualità e ha mantenuto una forte posizione di curiosità scientifica nell’esplorare questo argomento complesso, essendo consapevole e cosciente delle pressioni contestuali e culturali che influenzano la ricerca. Egli confermò che la sessualità è un fenomeno molto articolato e non semplice. Come nel caso del protagonista del film, questo dimostra come l’esplorazione del proprio orientamento sessuale non sia mai un processo lineare o semplice, ma richieda tempo, introspezione ed esplorazione. La sessualità cambia nel corso della vita e ogni viaggio è altamente personale e complicato. La gamma di emozioni, pensieri e sentimenti che si provano durante questo percorso sono del tutto normali e comprensibili.