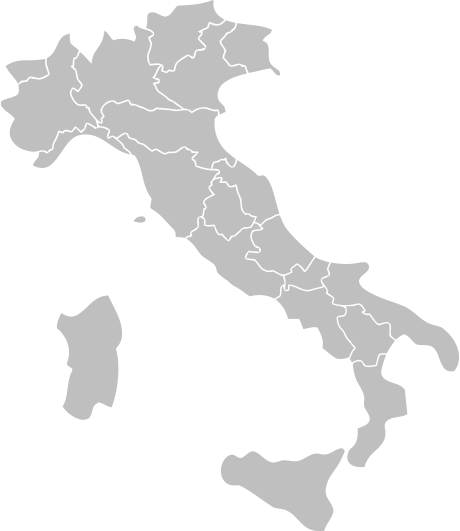Tra le relazioni più significative che un individuo stabilisce nel corso della vita, il legame fraterno rappresenta uno dei più duraturi e prioritari, in quanto va a caratterizzare e determinare la struttura della personalità. Tale legame ha alla base la condivisione dello stesso patrimonio genetico, familiare e culturale (Eriksen, Gerstel 2002) e tutto ciò consente di improntare le dinamiche relazionali necessarie per la definizione e comprensione dei ruoli sociali. Essendo i fratelli e le sorelle i protagonisti di un tipo di legame duraturo, coinvolgente e articolato, caratterizzato da vicinanza e collaborazione e allo stesso tempo da indipendenza e competizione, essi hanno la possibilità, attraverso il gioco, di acquisire di fatto la capacità di sviluppare competenze sociali come l’empatia e comprendere le regole che definiscono i ruoli sociali. Il forte impatto emotivo che scaturisce dal rapporto tra fratelli, infatti, è l’elemento chiave che renderà queste relazioni evolutivamente significative. Queste particolari dinamiche relazionali sono caratterizzate, come già accennato, da sentimenti ambivalenti che vedono alternarsi situazioni in cui i fratelli si scambiano supporto, condivisione e cure, ad altre in cui il rapporto è improntato sulla rivalità e l’odio.
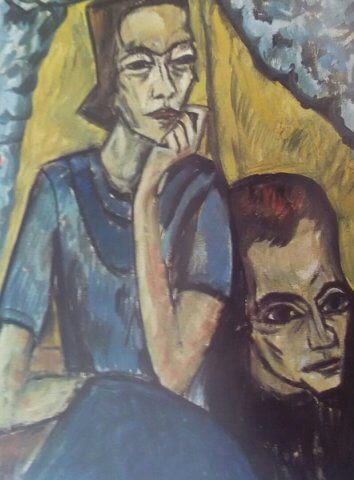 La psicoanalisi ha da sempre focalizzato l’attenzione sulla rivalità, riconducibile al complesso di Edipo e quindi al rapporto con i genitori. Ha trascurato invece, in un primo momento, le dinamiche interne alla relazione tra fratelli e al ruolo che ricoprono nello sviluppo psichico e affettivo infantile, in particolare quella particolare dinamica che viene definita “rispecchiamento”. Il rispecchiamento risulta essere di fondamentale importanza nella formazione di un iniziale senso di sé ed è la base di partenza per creare relazioni sane con gli altri. Il fratello non è solo un rivale con il quale contendere il primato dell’amore dei genitori ma è anche un altro bambino, nel quale rispecchiarsi e identificarsi. È su questo piano che i fratelli creano un loro mondo a parte, spesso sconosciuto agli stessi genitori, all’ombra dei quali intessono in segreto nuove forme di complicità, alleanza e solidarietà. Una riflessione maggiore sulle dinamiche psichiche inconsce che nascono nella relazione tra fratelli è stata sicuramente determinata dalle notevoli trasformazioni delle strutture familiari in collegamento con i mutamenti culturali, economici e sociali che hanno interessato il mondo occidentale dalla fine del XIX secolo. Kaës (2008) si è particolarmente concentrato sul complesso fraterno, non perdendo mai di vista però il collegamento che esiste tra il complesso di Edipo e appunto il complesso fraterno. Quest’ultimo, secondo l’autore, si situa all’interno del triangolo preedipico, costituito dalla relazione io-genitori-fratelli ed è proprio a partire dalle dinamiche relazionali che intercorrono in questa triade che si andranno a delineare le strutture di difesa e di identificazione con l’altro. Per poter meglio comprendere in che modo si articolino queste relazioni, alcuni autori francesi, Jaitin (2006) in particolare, hanno operato una distinzione tra “complesso fraterno” e “legame fraterno”. Si rende necessario specificare innanzitutto a cosa ci riferiamo quando parliamo di complesso: esso può essere esemplificato come un nucleo affettivo emotivamente carico, che si attiva nel bambino durante la primissima infanzia, caratterizzato dalla conflittualità. Nel complesso di Edipo tale conflittualità riguarda i sentimenti di amore e di odio per i genitori. Nel complesso fraterno, cosi come è stato delineato da Kaes, la conflittualità riguarda l’ambivalenza, la rivalità, l’amore narcisistico nei confronti di un altro individuo riconosciuto come fratello o sorella. Durante questo riconoscimento si attiva, all’interno del bambino, uno schema rappresentazionale prettamente soggettivo attraverso il quale il bambino si raffigura oggetti e personaggi. Il “legame fraterno” dunque mette in gioco i rapporti tra i differenti complessi di fratelli e sorelle quando sono in relazione, implicando diverse modalità di alleanza, conscia e inconscia, che fanno da collante allo spazio della realtà psichica del legame che s’inscrive nel romanzo familiare e nella filiazione intergenerazionale, cioè in un insieme immaginario e simbolico. Quando, attraverso le identificazioni reciproche, la fratria riesce ad elaborare un movimento funzionale di defusione e di differenziazione dal nucleo familiare originario, siamo in presenza di un narcisismo di vita, che a partire da un’alleanza magico-onnipotente contro la coppia genitoriale, spinge prima a un’alleanza con i genitori, poi verso l’autonomia. Al contrario, quando invece nella relazione fraterna prevale il volto mortifero del narcisismo, il patto denegativo (Kaës, 1989) tra i fratelli, potrà arroccarsi su una funzione difensiva rispetto ai movimenti evolutivi, che promuovono la separazione. L’incesto fraterno nascerebbe dunque dall’amore primario dell’infante per la madre e da una separazione difettosa che va a potenziare il rispecchiamento narcisistico dell’uguale. Probabilmente ciò delimita una cornice in cui ogni differenza è sentita come estraneità pericolosa, lo spazio della separazione è impossibile e il ripetersi dell’uguale è l’unica forma di continuità possibile, continuità che trova un’alleanza inconscia in un vulnus della generazione precedente che su quei figli viene proiettata.
La psicoanalisi ha da sempre focalizzato l’attenzione sulla rivalità, riconducibile al complesso di Edipo e quindi al rapporto con i genitori. Ha trascurato invece, in un primo momento, le dinamiche interne alla relazione tra fratelli e al ruolo che ricoprono nello sviluppo psichico e affettivo infantile, in particolare quella particolare dinamica che viene definita “rispecchiamento”. Il rispecchiamento risulta essere di fondamentale importanza nella formazione di un iniziale senso di sé ed è la base di partenza per creare relazioni sane con gli altri. Il fratello non è solo un rivale con il quale contendere il primato dell’amore dei genitori ma è anche un altro bambino, nel quale rispecchiarsi e identificarsi. È su questo piano che i fratelli creano un loro mondo a parte, spesso sconosciuto agli stessi genitori, all’ombra dei quali intessono in segreto nuove forme di complicità, alleanza e solidarietà. Una riflessione maggiore sulle dinamiche psichiche inconsce che nascono nella relazione tra fratelli è stata sicuramente determinata dalle notevoli trasformazioni delle strutture familiari in collegamento con i mutamenti culturali, economici e sociali che hanno interessato il mondo occidentale dalla fine del XIX secolo. Kaës (2008) si è particolarmente concentrato sul complesso fraterno, non perdendo mai di vista però il collegamento che esiste tra il complesso di Edipo e appunto il complesso fraterno. Quest’ultimo, secondo l’autore, si situa all’interno del triangolo preedipico, costituito dalla relazione io-genitori-fratelli ed è proprio a partire dalle dinamiche relazionali che intercorrono in questa triade che si andranno a delineare le strutture di difesa e di identificazione con l’altro. Per poter meglio comprendere in che modo si articolino queste relazioni, alcuni autori francesi, Jaitin (2006) in particolare, hanno operato una distinzione tra “complesso fraterno” e “legame fraterno”. Si rende necessario specificare innanzitutto a cosa ci riferiamo quando parliamo di complesso: esso può essere esemplificato come un nucleo affettivo emotivamente carico, che si attiva nel bambino durante la primissima infanzia, caratterizzato dalla conflittualità. Nel complesso di Edipo tale conflittualità riguarda i sentimenti di amore e di odio per i genitori. Nel complesso fraterno, cosi come è stato delineato da Kaes, la conflittualità riguarda l’ambivalenza, la rivalità, l’amore narcisistico nei confronti di un altro individuo riconosciuto come fratello o sorella. Durante questo riconoscimento si attiva, all’interno del bambino, uno schema rappresentazionale prettamente soggettivo attraverso il quale il bambino si raffigura oggetti e personaggi. Il “legame fraterno” dunque mette in gioco i rapporti tra i differenti complessi di fratelli e sorelle quando sono in relazione, implicando diverse modalità di alleanza, conscia e inconscia, che fanno da collante allo spazio della realtà psichica del legame che s’inscrive nel romanzo familiare e nella filiazione intergenerazionale, cioè in un insieme immaginario e simbolico. Quando, attraverso le identificazioni reciproche, la fratria riesce ad elaborare un movimento funzionale di defusione e di differenziazione dal nucleo familiare originario, siamo in presenza di un narcisismo di vita, che a partire da un’alleanza magico-onnipotente contro la coppia genitoriale, spinge prima a un’alleanza con i genitori, poi verso l’autonomia. Al contrario, quando invece nella relazione fraterna prevale il volto mortifero del narcisismo, il patto denegativo (Kaës, 1989) tra i fratelli, potrà arroccarsi su una funzione difensiva rispetto ai movimenti evolutivi, che promuovono la separazione. L’incesto fraterno nascerebbe dunque dall’amore primario dell’infante per la madre e da una separazione difettosa che va a potenziare il rispecchiamento narcisistico dell’uguale. Probabilmente ciò delimita una cornice in cui ogni differenza è sentita come estraneità pericolosa, lo spazio della separazione è impossibile e il ripetersi dell’uguale è l’unica forma di continuità possibile, continuità che trova un’alleanza inconscia in un vulnus della generazione precedente che su quei figli viene proiettata.
Tirocinanti: D’aprano Loredana, D’alessio Emanuela, Pinna Noemi
Tutor: Davide Silvestri.
Bibliografia
Eriksen S., & Gerstel N. (2002), A labor of love or labor itself: Care work among adult brothers and sisters. Journal of Family Issues, 23(7), 836-856, in Smorti M., & Guarnieri S. (2013), Le relazioni fraterne nel corso dello sviluppo,Carocci.
Jaitin R. (2006), Clinique de l’inceste fraternel, Dunod, Paris.
Kaës R. (2008), Il complesso fraterno, Borla, Roma 2009
Lockwood R. L., Kitzmann K. M., & Cohen R. (2001), The impact of sibling warmth and conflict on children’s social competence with peers. Child Study Journal, 31(1), 47-47, in Smorti M., & Guarnieri S. (2013), Le relazioni fraterne nel corso dello sviluppo, Carocci.
Smorti M., & Guarnieri S. (2013), Le relazioni fraterne nel corso dello sviluppo, Carocci.